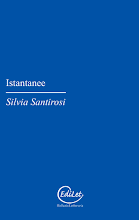Il 38esimo Festival internazionale del fumetto di Angoulême non delude offrendo al pubblico che arriva da ogni parte d’Europa (e non solo) quattro giorni intensi: conferenze, concerti illustrati, esposizioni di grande qualità e la possibilità di incontrare gli autori amati, per farsi autografare il loro fumetto o magari incrociandoli per strada.
Perché è tutta la città a mobilitarsi per il Festival, a trasformarsi in un luogo di festa e condivisione. E a noi dà la possibilità di incontrare Baru, il maestro del fumetto francese, l’autore di successi come L’autoroute du soleil (Coconino Press) o Gli anni Sputnik (Kappa edizioni) che “rifiuta” la definizione di artista.
Perché è tutta la città a mobilitarsi per il Festival, a trasformarsi in un luogo di festa e condivisione. E a noi dà la possibilità di incontrare Baru, il maestro del fumetto francese, l’autore di successi come L’autoroute du soleil (Coconino Press) o Gli anni Sputnik (Kappa edizioni) che “rifiuta” la definizione di artista.
Non vuole sottomettersi alla logica che vede il fumetto confinato in una specie di serie B della cultura, un prodotto per adolescenti, eterni adolescenti e imbecilli. Le cose sono cominciate a cambiare a partire dagli anni Settanta, ci dice, e sebbene oggi il panorama sia molto diverso persiste questo pregiudizio. Una cosa che ci sorprende, visto che la situazione decisamente peggiore in Italia.
Baru si appassiona quando parla del fumetto che per lui è un’esperienza emotiva e sinestetica: per questo non si è mai preoccupato troppo del realismo dei suoi personaggi: è qualcosa che nasce dal suo bisogno di raccontare ciò di cui si è sempre nutrito, le sue esperienze di vita. Ci racconta che ama raccontare storie di adolescenti, di ragazzi, non perché abbia nostalgia di quel periodo dell’esistenza, piuttosto per il tratto caratteristico della giovinezza: «la fame di vita».
Una fame che spesso non viene soddisfatta e per questo genera mostri. Ad esempio, in Povere nullità (Coconino Press, 2010) la novel graphic che nasce dall’adattamento di un romanzo di Pierre Pélot, sembra quasi di ritrovare la stessa atmosfera di Fargo, il film dei fratelli Cohen: quella della discesa infernale nella banalità del male. «Esattamente di questo volevo parlare» commenta Baru.
«Occupandomi di una storia ambientata in una piccola realtà che vive un disastro industriale, dove non c’è più lavoro per nessuno, ho potuto sezionare l’impoverimento materiale che diventa morale, analizzandone fino in fondo la logica. Il male non è un’astrazione, ma qualcosa di reale legato al crollo di una struttura sociale, un comportamento umano che credo fortemente legato alla disperazione. I protagonisti cercano di fuggire al determinismo che li vuole confinati in una modalità precisa, sono vivi e vogliono vivere diversamente, e si trovano a scontrarsi con la violenza di tale sistema».
Un lavoro nero che non concede nulla alla speranza. Nessuno spiraglio. Una visione pessimistica che non appartiene però del tutto all’autore che ama definirsi un ottimista-pessimista. «Anche se credo alla bontà di fondo dell’essere umano» così spiega la sua posizione contraddittoria, «sono scoraggiato dall’osservazione delle condizioni nelle quali vive e, dunque, può esprimere la sua natura».
Il suo eloquio si appassiona. «Sono convinto, per commentare la situazione politica contemporanea, che quello di Sarkozy sia solo un momento. Passeggero. E lo stesso mi auguro per l’Italia di Berlusconi. Viviamo in una società ancora accettabile, ma anche fortemente a rischio».
E continua parlando della sua concezione antropologica. «Qualunque persona è capace del peggio, eppure l’uomo ha la possibilità di combattere questa tendenza. E può farlo con l’immaginazione che non è qualcosa di innato. Si sviluppa e cresce nel confronto con gli altri e rende l’uomo migliore. Il problema è quando non ci sono stimoli, quando barriere e chiusure impediscono questo».
Un pensiero che diremmo socratico. Un’annotazione condivisa da Baru che spinge il resto della conversazione sullo stesso binario. Ecco allora che Aristotele diventa il pretesto per discutere del legame tra la cultura e cibo. Anzi, per Baru, non si può parlare di cultura della classe operaia, e di cultura in generale, senza parlare di cibo, «il valore del quale» si dice convinto, «dipende molto dal modo in cui viene guadagnato. Facciamo l’esempio degli immigrati italiani e al loro rapporto con la polenta e la pasta.
La prima era un cibo più legato all’idea di povertà che, con il miglioramento delle condizioni economiche, è stato raffinato e via via sostituito dal consumo dell’altro alimento. Per questo il rapporto con il cibo, come viene scelto, preparato e presentato, ha un valore soprattutto culturale. è la traccia tangibile della sua evoluzione». Inciampiamo a ogni passo nelle origini italiane di Baru, il padre era marchigiano, e le stesse sono ben vive nella sua produzione passata e futura.
«Gli italiani» ci racconta, «sono un esempio di integrazione riuscita. Sebbene rital fosse in passato una parola dispregiativa per dire italiano (un po’ come crucco per parlare di un tedesco, ndA), oggi ha assunto una sfumatura di legittimazione. Io sono un rital» dice Baru ridendo. Perché questo? «Per il semplice fatto che gli immigrati che sono venuti dopo ne hanno preso il posto. Gli immigrati italiani si sono integrati perché hanno avuto la possibilità di lavorare.
Al contrario degli arabi, ad esempio, condannanti oggi all’emarginazione. In altre parole non c’è ragione sociale di inclusione». Non ci stupisce, quindi, che tra i progetti futuri ci sia anche quello di raccontare proprio la storia di una famiglia italiana fuggita durante il periodo fascista, della sua integrazione riuscita e del prezzo pagato per ottenerla. E Baru non ha dubbi sul titolo: Bella ciao. Non ci resta che sperare che il suo editore sia d’accordo.
Baru si appassiona quando parla del fumetto che per lui è un’esperienza emotiva e sinestetica: per questo non si è mai preoccupato troppo del realismo dei suoi personaggi: è qualcosa che nasce dal suo bisogno di raccontare ciò di cui si è sempre nutrito, le sue esperienze di vita. Ci racconta che ama raccontare storie di adolescenti, di ragazzi, non perché abbia nostalgia di quel periodo dell’esistenza, piuttosto per il tratto caratteristico della giovinezza: «la fame di vita».
Una fame che spesso non viene soddisfatta e per questo genera mostri. Ad esempio, in Povere nullità (Coconino Press, 2010) la novel graphic che nasce dall’adattamento di un romanzo di Pierre Pélot, sembra quasi di ritrovare la stessa atmosfera di Fargo, il film dei fratelli Cohen: quella della discesa infernale nella banalità del male. «Esattamente di questo volevo parlare» commenta Baru.
«Occupandomi di una storia ambientata in una piccola realtà che vive un disastro industriale, dove non c’è più lavoro per nessuno, ho potuto sezionare l’impoverimento materiale che diventa morale, analizzandone fino in fondo la logica. Il male non è un’astrazione, ma qualcosa di reale legato al crollo di una struttura sociale, un comportamento umano che credo fortemente legato alla disperazione. I protagonisti cercano di fuggire al determinismo che li vuole confinati in una modalità precisa, sono vivi e vogliono vivere diversamente, e si trovano a scontrarsi con la violenza di tale sistema».
Un lavoro nero che non concede nulla alla speranza. Nessuno spiraglio. Una visione pessimistica che non appartiene però del tutto all’autore che ama definirsi un ottimista-pessimista. «Anche se credo alla bontà di fondo dell’essere umano» così spiega la sua posizione contraddittoria, «sono scoraggiato dall’osservazione delle condizioni nelle quali vive e, dunque, può esprimere la sua natura».
Il suo eloquio si appassiona. «Sono convinto, per commentare la situazione politica contemporanea, che quello di Sarkozy sia solo un momento. Passeggero. E lo stesso mi auguro per l’Italia di Berlusconi. Viviamo in una società ancora accettabile, ma anche fortemente a rischio».
E continua parlando della sua concezione antropologica. «Qualunque persona è capace del peggio, eppure l’uomo ha la possibilità di combattere questa tendenza. E può farlo con l’immaginazione che non è qualcosa di innato. Si sviluppa e cresce nel confronto con gli altri e rende l’uomo migliore. Il problema è quando non ci sono stimoli, quando barriere e chiusure impediscono questo».
Un pensiero che diremmo socratico. Un’annotazione condivisa da Baru che spinge il resto della conversazione sullo stesso binario. Ecco allora che Aristotele diventa il pretesto per discutere del legame tra la cultura e cibo. Anzi, per Baru, non si può parlare di cultura della classe operaia, e di cultura in generale, senza parlare di cibo, «il valore del quale» si dice convinto, «dipende molto dal modo in cui viene guadagnato. Facciamo l’esempio degli immigrati italiani e al loro rapporto con la polenta e la pasta.
La prima era un cibo più legato all’idea di povertà che, con il miglioramento delle condizioni economiche, è stato raffinato e via via sostituito dal consumo dell’altro alimento. Per questo il rapporto con il cibo, come viene scelto, preparato e presentato, ha un valore soprattutto culturale. è la traccia tangibile della sua evoluzione». Inciampiamo a ogni passo nelle origini italiane di Baru, il padre era marchigiano, e le stesse sono ben vive nella sua produzione passata e futura.
«Gli italiani» ci racconta, «sono un esempio di integrazione riuscita. Sebbene rital fosse in passato una parola dispregiativa per dire italiano (un po’ come crucco per parlare di un tedesco, ndA), oggi ha assunto una sfumatura di legittimazione. Io sono un rital» dice Baru ridendo. Perché questo? «Per il semplice fatto che gli immigrati che sono venuti dopo ne hanno preso il posto. Gli immigrati italiani si sono integrati perché hanno avuto la possibilità di lavorare.
Al contrario degli arabi, ad esempio, condannanti oggi all’emarginazione. In altre parole non c’è ragione sociale di inclusione». Non ci stupisce, quindi, che tra i progetti futuri ci sia anche quello di raccontare proprio la storia di una famiglia italiana fuggita durante il periodo fascista, della sua integrazione riuscita e del prezzo pagato per ottenerla. E Baru non ha dubbi sul titolo: Bella ciao. Non ci resta che sperare che il suo editore sia d’accordo.
Silvia Santirosi