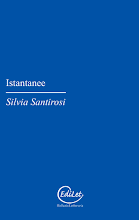Così comincia la mia avventura come recensore e intervistatore...tre anni fa, con la collaborazione a Stilos (poi diventato Il Sottoscritto).
Ecco uno dei primi intervistati: Giosuè Calaciura, scrittore che stimo molto, con cui ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare insieme a Fahrenheit (Radio3). Quella che vi propongo oggi è il pezzo scritto in occasione dell'uscita del suo libro Urbi et orbi (Baldini Castoldi Dalai, 2007).
Buona lettura!
______
In Urbi et Orbi Giosuè Calaciura racconta la cosca luciferina di prelati che ordisce trame ai danni di Dio, attaccando, ostacolando, il custode delle chiavi del suo paradiso. Un «io nar-rante» che è la prima persona plurale, un Noi che non ha né un volto né un nome, realizza un gioco di specchi che confonde il lettore, catapultato, senza neanche rendersene conto, nel ruolo d’attore. È così che quel Noi diventa un luogo, il luogo di quella «prigionia preventiva in assenza di condanna» che è il mondo, un mondo che aspira a Dio, ma, al tempo stesso, soffoca nelle spire del suo attorcigliamento inautentico, senza speranza. Abbiamo intervistato l’autore.
Come nasce questo libro?
Era il 28 settembre 2003, il giorno dopo la prima «Notte Bianca» a Roma. La città era ancora senza elettricità a causa del black-out totale che il giorno prima aveva creato non pochi disagi al milione e mezzo di persone che vi aveva partecipato. Volendo sapere cosa accadeva fuori della mia casa, ho acceso una mia vecchia radio e, in quel silenzio innaturale, mi è arrivata una voce di animale vecchio. Non l’ho capito subito, ma quello che le mie orecchie avevano percepito come un rantolo era la voce del papa. Era l’agonia di un uomo anziano, un uomo che stava morendo, ma era chiamato a portare il dolore di tutti. Quello è stato l’atto di nascita di un libro giocato nel mezzo, tra la possibilità di raccontare la massima mondanità e il massimo della santificazione in vita.
«Ci perdemmo quando ci ordinarono sacerdoti ». L’apertura del romanzo suona come l’epitaffio della fede. Non c’è più spazio per la fede?
Certo che c’è spazio per la fede. Il problema è che c’è troppo poco spazio per la spiritualità. Bisogna fare una precisazione. C’è una differenza fra religione e fede, perché la religione è ciò che ha a che fare con i valori assoluti dove non trovano posto il dubbio, la possibilità. La fede invece è laica, reversibile. Si può credere nell’uomo, in un ideale o nella ragione, ma si può sempre tornare indietro. Considero dunque la fede come lo spazio della spiritualità, che manifesta quella necessità di trascendenza proprio dell’uomo, una necessità senza risposta, se non quella che noi stessi costruiamo vivendo.
Quindi, senza Dio non tutto è perduto, e proprio perché Dio tace, è l’uomo che deve far sentire la sua voce.
Sono assolutamente pessimista. Il gruppo di sacerdoti che immagino provenire dal Meridione italiano, dal mio Meridione, ha perso qualsiasi tipo di spiritualità e considera Dio alla stregua delle altre merci, un elemento di consumo, un fenomeno da baraccone. La cosa tragica è che hanno perso anche la loro identità, vivendo una condizione di contorcimento antropologico senza speranza.
Perché la prima persona, anche se plurale? E perché invece ne La figlia perduta sceglieva di parlare in terza persona?
La scelta e l’uso della prima persona è quasi manieristico. È come se gli stessi protagonisti, la stessa cosca affrontassero un altro indicibile: in Malacarne era la mafia, in Urbi et Orbi a farsi indicibile è la santità. Per quel che riguarda La figlia perduta, avevo invece bisogno della favola perché prevede una parabola aperta, una possibilità di redenzione. Aggiungiamo pure che è stato un lavoro commissionato da Amref e che mi ha visto conoscere persone per le quali provo un affetto che rendeva urgente il racconto. Avevo bisogno di distaccarmi. Ogni racconto di viaggio è un raccontare se stessi, un mettere sulla brace la tua identità. Poiché ho trovato un filo che lega il mio Meridione a quel Meridione. Quando sono arrivato a Kampala non mi sono sentito un estraneo. Lo slum è un luogo di degrado, di sradicamento, di identità che si scontrano. È molto più difficile raccontare ciò che si riconosce come familiare.
Quello che colpisce dei suoi romanzi sono lo stile e una specie di etica del fare.
Se c’è una speranza, è proprio quella della creatività della scrittura, del linguaggio. Non può fare nulla, anche perché, purtroppo, i numeri della letteratura sono quello che sono. L’importante, tuttavia, è il senso che lasci, è aver detto. Vivo, come altri scrittori, una situazione di marginalità perché la mia scrittura non può diventare una sceneggiatura cinematografica. Il mio tentativo è recuperare il valore della pagina scritta, fatta di grammatica, di sapienza nel costruire la frase, di ritmo. Oggi si tendono a scrivere sceneggiature. Ma le cose che si vengono raccontate entrano in una sorta di cortocircuito: si scrive sempre la stessa cosa.
Cosa pensa della cultura italiana di oggi?
L’Italia ha una grande colpa. Quella di avere chiuso gli occhi sul Meridione, sulla potenzialità culturale del Meridione, quasi privandosi di una gamba. Come ha fatto la cultura italiana a misconoscere uno scrittore come Michele Perriera, attori (e non solo) come Franco Scaldati, Aurora Quattrocchi (che ultimamente abbiamo visto nel film Nuovomondo di Emanuele Crialese). In Italia c’è un salotto dove si consumano le stesse cose, chi le consuma vi fa parte, chi non le consuma o ha un linguaggio diverso, è insomma un elemento di originalità, deve restarne fuori. Ma, come direbbe Zagrebelsky, è una pessima cosa per la democrazia, mettere di lato l’originalità, i contenuti minoritari, magari legati a situazioni spiacevoli.
Ad ogni suo libro potremmo associare un tema: a Malacarne quello della mafia, a Sgobbo quello della prostituzione, a La figlia perdutal’Africa, ad Urbi et Orbi il papato. Eppure tutti sembrano attraversati da una stessa tensione realistica.
Infatti. Tutti i miei libri parlano sempre della stessa cosa, di un’esperienza esistenziale. Sono diverse incarnazioni della stessa emarginazione dal mondo e, dall’altra parte, della stessa cattiveria del mondo. Sembrerà blasfemo mettere insieme una prostituta nigeriana e il papa, ma quello che mi interessa sono gli aspetti più profondi del nostro essere uomini. Non c’è uomo né donna. C’è l’essere umano che si confronta, combatte e, ahimè, perde nel suo stare al mondo, gettato dal cielo e raccolto dalla terra. In Malacarne è un morto che parla, perché i morti, ed i non-nati, hanno il tocco della consapevolezza. La parabola è quella del male e del dolore, però noi che stiamo dall’altra del foglio, proprio leggendo, siamo stimolati ad essere diversi e a dire no, consapevoli, al tempo stesso, del nostro limite, della morte, della nostalgia, delle perdite. Racconto storie di condannati, quindi, proprio perché penso di stimolare a scegliere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA